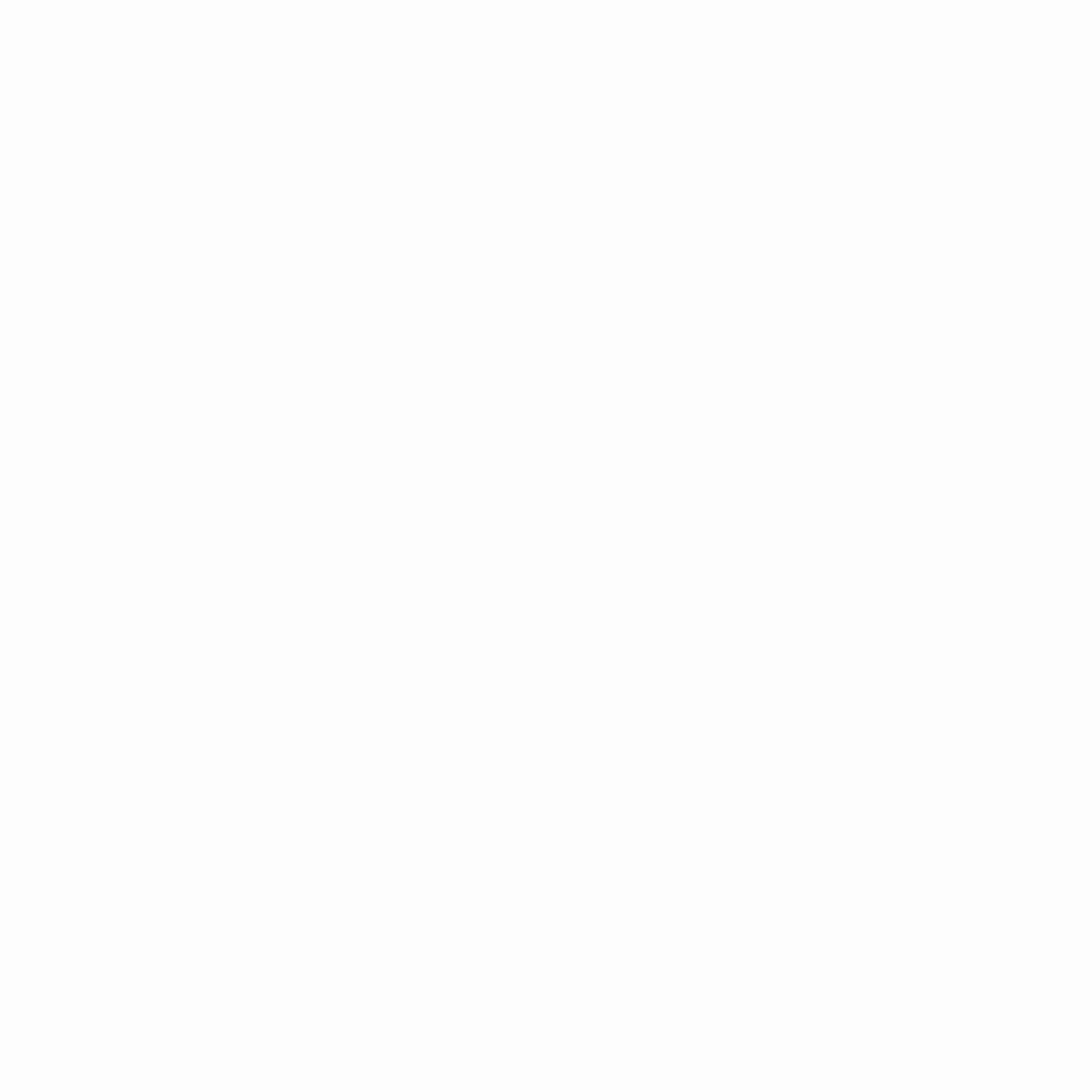Parole Attorno al Fuoco
Concorso del Gruppo di Arcade – Sezione di Treviso
Da quando mesi fa ci venne chiesta dal Gruppo di Arcade (TV) la possibilità di pubblicare questo articolo sul nostro sito, per poter allargare ad un pubblico più vasto la conoscenza e la possibilità a cimentarsi in questo concorso, esso è rimasto sempre nella Home Page. Il 5 gennaio 2012 è avvenuta la premiazione del concorso. Il vincitore è stato il racconto “Il sasso nel bicchiere” di Michele Piccolino Ausonia di Frosinone. Potete di seguito trovare il link al racconto e a tutti gli altri testi che sono stati encomiati.
|
Il sasso nel bicchiere Di MICHELE PICCOLINO AUSONIA (FR)
|
| 4 luglio 2009
Prima di partire passo da Silvia per un caffè e per un incoraggiamento, sapendo benissimo che avrò il primo ma non il secondo. — Dai, papà, entra che ho già la caffettiera sul fuoco. Mette nella tazzina un cucchiaino scarso di zucchero e versa il caffè. — Ce l’hai una cartina? — mi chiede. — Ho preso un navigatore. — spiego. Silvia alza gli occhi al cielo e caccia un sospiro rassegnato. — Tu sei pazzo, lo sai, vero? — continua, sorridendo, — Potresti girare per mesi senza trovare niente. — aggiunge, ma non vuole scoraggiarmi. Vuole solo avere l’opportunità tutta femminile di dire un giorno “io te l’avevo detto”. — Non starò via tanto, stai tranquilla. Un mese, non di più. Se non riesco in questo mese, lascio perdere, prometto. — Speriamo. Chissà che avrebbe detto la mamma… — butta lì la cosa con finta noncuranza. — Tua madre a quest’ora starebbe già sul caravan a suonare il clacson per farmi fretta. È tardi, sono già le 8.00, tra poco incomincerà a fare caldo. Silvia mi regala l’ultimo sospiro della sua disapprovazione d’ufficio e mi abbraccia, stringendomi forte. — Buona fortuna, pescatore. — mi sussurra in un orecchio. Sento nella sua voce un filo di commozione, la stessa che ingarbuglia le parole nella mia gola. — Ciao. Non ti preoccupare, capito? — biascico con gli occhi umidi mentre mi separo da lei. — Sì, ma chiamami. Tutti i giorni, mi raccomando. Salgo sul caravan e metto in moto. La prima tappa è Pederobba. Sul sedile del passeggero ho l’ingrandimento della foto e i fogli con l’elenco dei Turrin diviso secondo l’ordine dei paesi che incontrerò in viaggio. Alla mia sinistra, sotto l’argine, il Piave scorre sonnacchioso e basso, con la secca la sponda ghiaiosa guadagna spazio verso il centro del fiume ogni giorno che passa. Quando trovai il ciondolo, sedici anni fa, era un giorno così. All’alba mi ero spinto lungo la sponda fangosa armato di stivali fino alle anche e di canna da pesca. I miei piedi smuovevano il fango che si perdeva con una lunga lingua limacciosa nella debole corrente della riva. Quando il sole fu abbastanza alto da specchiarsi nel fiume, un riflesso d’oro ai miei piedi attirò la mia attenzione. — Che cosa hai pescato? — mi chiese a casa mia moglie, venti minuti dopo. — Questo. — e gli porsi un pugno di fango. Anna, senza esitare, mise quella manciata di fango nel lavello e aprì il rubinetto. L’acqua lavò via la terra e rivelò un ciondolo d’oro, con poche maglie di una catenina spezzata all’altezza dell’occhiello. Anna asciugò il ciondolo per bene, accarezzando i graffi fatti dai ciottoli del fiume sul dorso della cassa d’oro, delicatamente, come fossero cicatrici sulla carne. Ricordo benissimo la nostra emozione quando lei aprì il ciondolo. Il piccolo cardine cigolò e le due metà si dischiusero con uno schiocco. All’interno, nell’ovale, c’era una piccola foto in bianco e nero che il sottovuoto aveva preservato dall’acqua. — Questa foto. — dico, due ore dopo la partenza, ai quattro anziani avventori del bar sulla piazza di Pederobba cui mostro l’ingrandimento. I quattro si avvicinano alla foto e scrutano il volto del bambino ritratto: avrà sì e no cinque/sei anni, le guance paffute e rubiconde, gli occhi scuri e intelligenti, un naso aggraziato sopra labbra piccole, i capelli pure scuri, con la riga a destra. — Roba degli anni ’50. — fa uno dei quattro. — Al massimo inizi ’60. Foto così professionali e artistiche, con i margini sfumati, non si fanno più da un pezzo. — aggiunge un altro. I quattro pederobbesi per qualche secondo cercano nei loro ricordi un riscontro all’immagine che hanno davanti agli occhi. Poi, con una smorfia della bocca, mi danno il loro verdetto: non conoscono il bambino della foto. — Ma non vuol dire niente. — aggiunge uno vedendo la mia faccia delusa, quasi volesse consolarmi. — Ci sono delle famiglie Turrin a Curogna e Molinetto. Può chiedere a loro. — conclude il più anziano dei quattro, — Anzi, l’accompagno io. Conosco bene il vecchio Giacinto Turrin: se il ragazzino non lo conosce lui, allora è meglio che cerchi da un’altra parte. Partiamo subito. Mentre guido, sento crescere l’eccitazione, quella della pesca, di quando lancio l’amo in un punto sperando che sia quello buono. Ci vogliono sempre parecchi lanci prima che qualcosa abbocchi ma ogni volta che vedo la lenza svolgersi in volo l’eccitazione è la stessa. La stessa di adesso. 10 luglio 2009 Parcheggio il caravan davanti al piccolo museo della prima guerra mondiale di Caorera, frazione del comune di Vas. Sulla soglia mi aspetta Giorgio Biasiotto, il sindaco e il curatore del museo. — Da appassionato di storia locale, trovo la sua spedizione molto affascinante, anche se piuttosto difficile. Ma lo sa quanti Turrin ci sono lungo il Piave? E in tutto il Veneto? Per tacere di quelli che sono sparsi per l’Italia… — ci tiene a spiegarmi. Lo so bene. I buchi nell’acqua che ho collezionato in questi giorni a Bigolino, S. Vito, Segusino, Alano e Quero me lo hanno confermato. Continuo a lanciare il mio amo ma di pesci neanche l’ombra. — Posso vederlo? — azzarda Biasiotto. Dal taschino della camicia estraggo il ciondolo. Il sindaco lo accoglie nel palmo della mano, come fosse una reliquia. Scruta il monile, studiandone la cassa da ogni angolazione. Poi lo apre e guarda la foto, quella che gli ho già mandato in allegato alla mail. — Mi spiega come ha fatto a stabilire che si chiama Turrin? Sulla cassa non c’è scritto nulla. Fu una grande intuizione di Anna, spiego. — Insomma, è chiaro che si tratta di una foto professionale. E quanti fotografi ci saranno stati in quegli anni? Non credo molti. Facile che nello studio di quel fotografo arrivassero molti negativi da sviluppare e per non confondersi lui scrivesse il nome del cliente dietro ogni foto. — ragionò mia moglie. Con una piccola pinza dalle punte aguzze staccai delicatamente la piccola foto dall’incavo ovale e sul retro trovai scritto quel cognome. — Se non avessi trovato questo piccolo indizio, non mi sarei mai imbarcato nell’impresa di ritrovare il bambino del ciondolo. — concludo. — Tutto ciò le fa onore. Ma è difficile, dopo tutti questi anni, circa cinquanta, giusto?, ritrovare quel bambino. Sempre ammesso che sia ancora vivo e abiti lungo il Piave. Ma Stanley, quando ritrovò Livingstone, aveva molte meno possibilità di lei, o no? Sorrido pensando che è vero. La speranza che la mia pesca sia fortunata è ancora intatta. — Comunque, ieri sera ho fatto vedere la foto alle due famiglie Turrin che abbiamo in paese. Niente da fare, non lo conoscono né sanno suggerire altre piste. Mi dispiace. Lo ringrazio, cercando di non mostrare la mia delusione. Incomincio a farci l’abitudine, alla delusione. — Le ho preparato un elenco di persone a cui si potrà rivolgere durante la sua ricerca. Si tratta di studiosi di storia locale, cui ho già annunciato la sua possibile chiamata. Se potranno, saranno lieti di aiutarla. Dopo una breve visita al museo, mi congedo. Me ne vado con qualche nome in più e alcune certezze in meno. 15 luglio 2009 La signora Esmeralda, la badante di Don Gelindo, ci porta una limonata e dei biscotti. Posa il vassoio sul tavolino e ci lascia soli, non senza proclamare che i biscotti li ha fatti lei. — Panta rei, tutto scorre — fa il vecchio parroco di Lentiai, da anni in pensione, — anche un ciondolo scorre come un ciottolo di fiume. La limonata è fresca e poco zuccherata. Mangio un biscotto che, dopo la limonata, mi sembra dolcissimo. — Mangi, mangi: Esmeralda ci tiene. — mi sollecita Don Gelindo mentre studia la foto del bambino. Mentre sbocconcello un altro biscotto, penso a quante volte ho già raccontato la storia del ciondolo e della mia ricerca. Ormai, la recito come una filastrocca, con il piglio cantilenate di una guida del Louvre di fronte alla millesima comitiva di visitatori. — No, non mi dice niente. — sentenzia dopo un minuto di scrupolosa opera di scandaglio nella sua memoria ultraottuagenaria. — Di Lentiai e dintorni non è di sicuro. Conosco vita, morte e miracoli di tutti gli abitanti di questo paese. Miracoli, pochi in verità; morte, parecchia: guerra, fame, alluvioni, frane e disastri vari in questa terra, fino a non molti anni fa, non sono mai mancati. Annuisco, spuntando mentalmente dall’elenco tutti i Turrin di Lentiai. — Lei non è veneto, giusto? — mi chiede guardandomi da sopra gli occhialini. No, sono di origini marchigiane, rispondo. L’accento, nonostante viva a Vidor da oltre trent’anni, non mente mai alle orecchie di chi sa ascoltare. — Ero ferroviere, del compartimento di Treviso. A me e a mia moglie Anna il Piave piacque subito e abbiamo deciso di rimanere. Mia figlia Silvia è nata a Valdobbiadene e si sente veneta a tutti gli effetti. — spiego. — Glielo chiedo perché, sa com’è, è singolare che un forestiero mostri così tanta passione per la nostra terra. Sorrido, un po’ lusingato e un po’ imbarazzato. — Questa ricerca l’ho progettata per tanti anni con mia moglie Anna. Era il nostro passatempo, la prospettiva che ci eravamo data per quando sarei andato in pensione. Mia moglie pensava spesso alla povera madre che aveva perso quel ciondolo nel fiume e immaginava il dispiacere che doveva aver provato. Oggi non faccio altro che onorare la memoria di mia moglie cercando di portare a termine il nostro progetto. Don Gelindo mi sorride, poi chiama la sua badante. — Esmeralda, da’ al nostro ospite quei libri che ho preparato ieri sera. — ordina indicando un pacco in un angolo della libreria. — Lei è animato da ottime intenzioni, — continua rivolgendomi i suoi occhi penetranti, — vuole risalire alla storia di questo ciondolo, ma credo conosca poco della storia di questa terra. Accolgo il pacco che si rivela pesare un po’ e faccio per andarmene. Esmeralda mi rifila anche un cartoccetto di biscotti. — Mi raccomando, li legga. Sono libri di storia locale. Lì capirà qualcosa di più di questa terra e, magari, troverà spunti e indizi per trovare la parola fine della sua storia. Ringrazio e vado via. Stasera mi dedicherò alla lettura. 2 agosto 2009 Il mese che mi sono dato come limite sta per finire. Come la speranza di riuscire. A quante persone avrò chiesto? In quante case sarò entrato? Ho perso il conto. Solo Belluno mi ha portato via sette giorni, una marea di Turrin sull’elenco. Ricevo un sacco di telefonate e di mail. La voce si è sparsa, i Turrin da tutto il Veneto vogliono aiutarmi. Finora, nessuno c’è riuscito. Chiamo Silvia tutti i giorni, come da promessa. Ogni giorno m’invita a fare ritorno a casa. Non so se vado avanti più per non dargliela vinta che per reale convinzione. Sento esaurirsi la spinta che Anna mi ha lasciato. Ho letto quasi tutti i libri di Don Gelindo. Tanta guerra, soprattutto la prima, ma pure la seconda; tanta fame e altrettanta povertà, storie di emigrazioni di massa, storie che la ricchezza degli ultimi decenni non hanno cancellato. Almeno non del tutto. Non ho più elenchi da spuntare, ho risalito il corso Piave per oltre settanta chilometri, non pensavo di spingermi più a monte di Soverzene. Sfoglio l’ultimo libro di Don Gelindo, “Le famiglie di Longarone prima del 1963”, leggo che anche lì c’erano dei Turrin. Forse domani ci vado. L’ultima tappa e poi a casa, dove tornerò a dedicarmi alla pesca, quella vera. Mi pare già di sentire i rimproveri canzonatori di Silvia. 3 agosto 2009 Prima di arrivare a Longarone, il mio occhio coglie il campanile di Pirago e, più su, tra due coste di montagna che sembrano quasi toccarsi, la diga del Vajont. Supero il cimitero e m’inoltro nel centro della cittadina, pulita, nuova, come un gioiellino ancora nel suo cofanetto. Percorro Via Roma fino al municipio e chiedo a un vigile dove abitano i Turrin. — Turrin? C’è solo Alfredo Turrin a Longarone. — e mi fornisce le indicazioni per raggiungere l’ultima tappa del mio viaggio. Trovo subito la villetta che il vigile mi ha descritto. Nel giardino un uomo sta sistemando della legna appena tagliata. Prendo la foto e mi avvicino. — Buongiorno. — dico quando mi trovo subito dietro il cancello. L’uomo pare non fare caso a me. Ripeto il mio saluto ma non ottengo risposta. — E’ lei Alfredo Turrin? — domando. L’uomo continua ad ammonticchiare i pezzi di legno e, senza girarsi verso di me, risponde che sì, è lui. — Volevo chiederle se conosce il bambino ritratto in questa foto. — aggiungo sporgendo la mano con la foto oltre le sbarre del cancello. Alfredo Turrin si rialza dal cumulo di legna e si volge nella mia direzione. Mi basta guardarlo in faccia per rendere superflua la sua risposta. L’uomo che mi sta di fronte dimostra una cinquantina d’anni, ha i capelli brizzolati con la riga a destra, guance paffute imporporate dallo sforzo, un naso che scende con grazia dalla fronte sudata, un paio di baffi incorniciano delle piccole labbra. Ma è il suo sguardo a darmi la certezza: nei suoi occhi scuri c’è la stessa luce che rischiara quelli del bambino della foto. Si avvicina al cancello senza smettere di fissare la foto. Quando è a un passo da me, la prende e la guarda come se di fronte a lui passasse un intero esercito di fantasmi. Le sue gote rubiconde si fanno pallide come bucaneve e il labbro inferiore è scosso da un fremito elettrico. — Dove l’ha presa? — farfuglia dopo un po’ mentre apre il cancello per farmi entrare. Gli porgo il ciondolo, con la stessa emozione che deve aver provato Schliemann di fronte alle rovine di Troia. Turrin lo prende e appena lo tocca viene travolto da un’ondata di piena fatta di ricordi. La diga che ha trattenuto le sue lacrime cede quando lo apre e si rivede bambino. — E’ un miracolo. — ripete tra i singhiozzi mentre accarezza il ciondolo come fosse la testa di suo figlio. Non so come, ci ritroviamo abbracciati, lui che piange sulla mia spalla, io sulla sua. Dopo un po’, Alfredo Turrin mi conduce nel tinello, prende due bicchieri e una bottiglia di clinto fresco. Ci sediamo intorno a un tavolo di legno, beviamo, un bicchiere, poi un altro. — Mi racconti. — mi fa dopo il terzo bicchiere. Stavolta la mia storia, quella che ho ripetuto in queste ultime settimane, perde la sua cadenza di cantilena e si fa musica e immagini per il mio nuovo amico. Alla fine, Alfredo Turrin appare soddisfatto. Stringe il ciondolo con forza, le dita quasi esangui per la stretta, come volesse essere certo che esiste davvero. Mi conduce di nuovo in giardino. Di fronte c’è la parete altissima della diga del Vajont. — La sera del 9 ottobre 1963, — racconta, — io, neanche sei anni, e mio padre Luigi eravamo a Casso, sopra l’invaso, nella parte alta del paese, ospiti di parenti. Il giorno eravamo andati per funghi. Mia madre Piera era rimasta giù a Longarone a badare alle bestie. Quando il monte Toc venne giù, noi eravamo già a letto. La forza d’urto della massa franata creò due ondate. La prima, a monte, venne spinta verso il centro della vallata del Vajont. Le case più basse vennero spazzate via in un attimo. La seconda scavalcò la diga precipitando a piombo nella vallata con una velocità impressionante. La stretta gola del Vajont la compresse ulteriormente, sparandola come un proiettile. La prima casa di Longarone che incontrò sulla traiettoria era la nostra. Allo sbocco della valle l’onda era alta settanta metri. La gente si rese conto di quello che stava per accadere, ma non poté scappare. Case, chiese, osterie, statue, piazze e strade vennero sradicate fino alle fondamenta. Quando l’onda perse il suo slancio andandosi ad infrangere contro la montagna, tornò indietro e fece tutto liscio fino al Piave. E’ lì, la mattina dopo, si affacciò mio padre. Un paese intero, migliaia di persone, compresa mia madre, il giorno prima c’erano, il giorno dopo erano terra. Un sasso era caduto in un bicchiere e l’acqua era uscita sulla tovaglia, questa la spiegazione che ci propinarono per anni. Sento che nella voce di Alfredo Turrin la rabbia ha preso il posto della commozione. Mi porta al cimitero, dove centinaia di lapidi formano un fiume di marmo. Si ferma davanti a una tomba che porta il nome di Piera Aldrigo in Turrin. — Questa tomba è vuota. Il giorno dopo, l’acqua del Piave era nera, portava giù di tutto: carcasse di animali, alberi sradicati, automobili rovesciate. Le sponde erano piene di gente, spalla a spalla, civili e militari, girati verso l’acqua, ognuno una pertica in mano. Con quelle pertiche fecero un pettine per fermare i morti che, in mezzo al resto, venivano giù sul filo della corrente. Quel giorno la gente da ogni parte del Veneto mollò tutto e andò a fare un dente del pettine lungo il fiume. Ma nel pettine non rimase impigliata Piera Turrin. Della mia casa non rimase nulla, neanche una pietra. A me e a mio padre, neanche il conforto di una salma da piangere, di una foto, di un oggetto qualsiasi. Apre il pugno in quella che adesso sembra una carezza e il ciondolo scintilla al sole come una piccola stella. — Non avevo niente che appartenesse a mia madre, niente che me la ricordasse. Fino ad oggi. — aggiunge, con le lacrime che hanno ripreso a stillare dai suoi occhi. Resto al suo fianco, davanti alla lapide, in silenzio. Con una mano gli stringo una spalla, sento il suo respiro placarsi, i muscoli sciogliersi un poco. Si gira e mi sorride. — Grazie. — mi fa. Annuisco e sorrido a mia volta. Mi piacerebbe tanto che potesse ringraziare anche Anna. |
Vecchio articolo del 7 luglio 2011
Il Gruppo di Arcade (TV) ha promosso un concorso letterario, che verrà premiato ad Arcade il 5 gennaio 2012. Su richiesta del Gruppo, pubblichiamo volentieri l’articolo, per poter allargare ad un pubblico più vasto la conoscenza e la possibilità a cimentarsi in di questo concorso.
Per maggiori dettagli clicca sull’immagine o visita il sito www.alpiniarcade.it
Il progetto culturale “Parole Attorno al Fuoco”, nato nel 1996 trova nel suo sottotitolo “genti, soldati e amanti della montagna: storie e problemi di ieri e di oggi” la perfetta collocazione nel panorama culturale della nostra terra. Le vicende che gli autori ci fanno conoscere hanno talvolta il sapore delle storie narrate attorno al camino o nelle stalle durante le lunghe sere d’inverno. Molte parlano di ricordi di guerra, di vicende eroiche, di amor di Patria, altre affrontano problemi nuovi che la montagna amplifica, altre prendono in considerazione la donna, nella sua antica tradizione di angelo del focolare, di bambini costretti ad imparare la dura lezione della vita in montagna. Altre ancora affrontano problemi in modo ironico, ma quasi tutte sono rispettose della dignità della vita di montagna.